






| |
Scrivici! |







| |
Scrivici! |
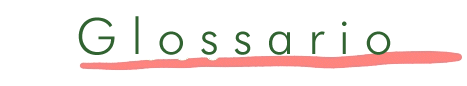
|
Indice Glossario |
Burattini a guanto, burattino a guaina, teste di legno
I burattini sono mossi dal basso verso l'alto. La mano del burattinaio entra
in un buratto di stoffa sotto il vestito, quindi il corpo del burattino è
composto da due strati di stoffe. Il primo, quello interno, è il buratto di
stoffa rigida (canapa) con le cuciture verso l'esterno; il secondo quello
esterno visibile dal pubblico è l'abito. La parte interna - guanto- si cuce
sulla misura della mano del burattinaio. A questo guanto detto buratto,
s'inchiodano la testa e le mani, solitamente in legno di cirmolo, olmo,
pioppo o faggio. In fondo, dove si infila la mano, nella parte dietro rispetto
la faccia del burattino, si cuce un gancio o un anello per appenderlo a testa
in giù all'asse dei burattini, dove si trovano ganci a elle o il righetto, a
seconda delle zone geografiche. Quest'asse, o l'assa dei burattini come di
dice a Bologna, è attaccata all'interno della baracca, all'altezza della cintura
del burattinaio, sotto la ribalta (proscenio della baracca). S'infilano l'indice E' chiaro quindi che il buratto non deve essere troppo largo, o troppo stretto, rispetto la mano che vi s'infila, altrimenti non si ottengono i movimenti accurati e desiderati. Il secondo vestito o abito, quello esterno, è “finto”, per apparire. Non serve per il movimento, ma per identificare l'appartenenza del personaggio ad una determinata casta e classe sociale. Solitamente divisa in popolani, contadini, borghesi, ecclesiasti, nobili, Re ed Imperatori. I burattini generici: gendarmi, briganti, bambini, giovanotti, uomini e vecchi, hanno un vestito intercambiabile, che viene fissato con uno spillone nel braccio al buratto sottostante, affinché lo stesso burattino diventi ogni sera un personaggio diverso. Vi si possono aggiungere parrucche, cappelli, armature e vestiti di epoche storiche e luoghi differenti. Altrimenti troviamo sempre con lo stesso abito, cucito al buratto, le Maschere cioè gli Zanni: Brighella, Arlecchino, Pantalone, Ballanzone, gli Innamorati, i Capitani di ventura e Pulcinella (anche se per quest'ultimo bisognerebbe aprire il longo discorso, data la sua antichissima provenienza che lo si vuole far risalire al mito egiziano di Iside e Osiride, o a quello greco di Hermes e Afrodite), e le Maschere Regionali o Caratteri: i personaggi rappresentativi delle diverse città italiane nati senza la maschera perché ideati da burattinai e marionettisti durante e successivamente il periodo napoleonico, dove era vietato l'uso della maschera perché sotto di essa poteva celarsi un nemico o un ricercato. Quindi col volto non mascherato troviamo: Fagiolino, Sganapino e Flemma a Bologna; Sandrone, la moglie Pulonia e il figlio Sgorghiguelo (famiglia Pavironica) a Modena; Scunzamnestra e Lasagnin a Ferrara; Gianduja a Torino; Meneghino a Milano; Stenterello a Firenze; Gioppino, la moglie Margì, Bartolo il padre e Maria Scatolera la madre, tutti coi tre gozzi o granate a Bergamo; Vladimiro Falesi meglio noto come Bargnòcla, per il grande bernoccolo a forma di osso di prosciutto, creato da Italo Ferrari a Parma nel 1914; Rugantino, Meo Patacca, Gaetanaccio a Roma; Beppe Nappa in Calabria, e Berlikete, l'ultimo nato in ordine cronologico, ideato nel 2005 dai burattinai Vittorio Zanella, Rita Pasqualini e dall'illustratore Marco Paci , onorati di poter creare un nuovo carattere regionale, nato sotto il segno dei Gemelli, che vuole rappresentare il carattere del Popolo Ladino. Questo primo esemplare è depositato presso l'Istituto e Museo Ladino di Vigo di Fassa (TN). L'etimologia del termine “burattino” deriva da “buratto” (“buràz” in bolognese = strofinaccio o “Sdaz” = setaccio, utilizzato per separare la farina dalla crusca e impurità), che era una stoffa di canapa, se a trama larga, serviva per setacciare le granaglie quando si mischiavano sull'aia dove erano messe ad essiccare, se a trama stretta, per lanciare in aria il chicco di grano per far volar via col vento la pula o crusca. La canapa veniva macerata nei maceri, filandola e sbiancandola al sole. Con questa stoffa si facevano anche i vestiti, le corde delle navi e i tiri dei teatri, comprese le stoffe interne dei burattini. Altri vogliono la derivazione del nome burattino provenire da burro: da mantecareimburattare- buratto-burattino. Oppure a buttarello o burattello = setaccio, E' chiaro in definitiva che il gioco dei burattini, come divertimento dei poveri, nasce nelle campagne dove durante le lunghe e fredde notti dell'inverno, quando non c'era più molto da fare, i contadini intagliavano nei ciocchi di legno le teste e le mani, le moglie cucivano i vestiti e tirando una corda tra una colonna e l'altra della stalla, facevano i burattini per il proprio contado. La stalla è quindi, in Emilia, anche il luogo dove si fa filò, cioè il luogo più caldo dove si chiacchierava e dove si filava. Successivamente i burattini conquistano le città dove il pubblico aveva maggiori possibilità economiche, quindi nell'800 vediamo la nascita di innumerevoli compagnie teatrali che dal 15 di maggio al 15 di settembre affittavano ai comuni d'appartenenza le piazze pagando il plateatico. Chi stava seduto pagava un biglietto, mentre chi stava in piedi, donava una elemosina al segretario che passava allungando il borsello per le offerte. Con l'avvento del cinema prima e della televisione poi, il mestiere entra in un grave declino che costringe la chiusura di molte compagnie di burattinai che abbandonarono per sempre l'antica attività ereditata dai padri. Per fortuna dagli anni '70 l'arte di far muovere i burattini ha ripreso vigore, anche grazie al rinnovamento dei testi, dei personaggi e delle tecniche d'animazione, più legati alla rinnovata pedagogia che vuole i bambini maggiormente al centro dell'attenzione come futuri cittadini del Mondo. |